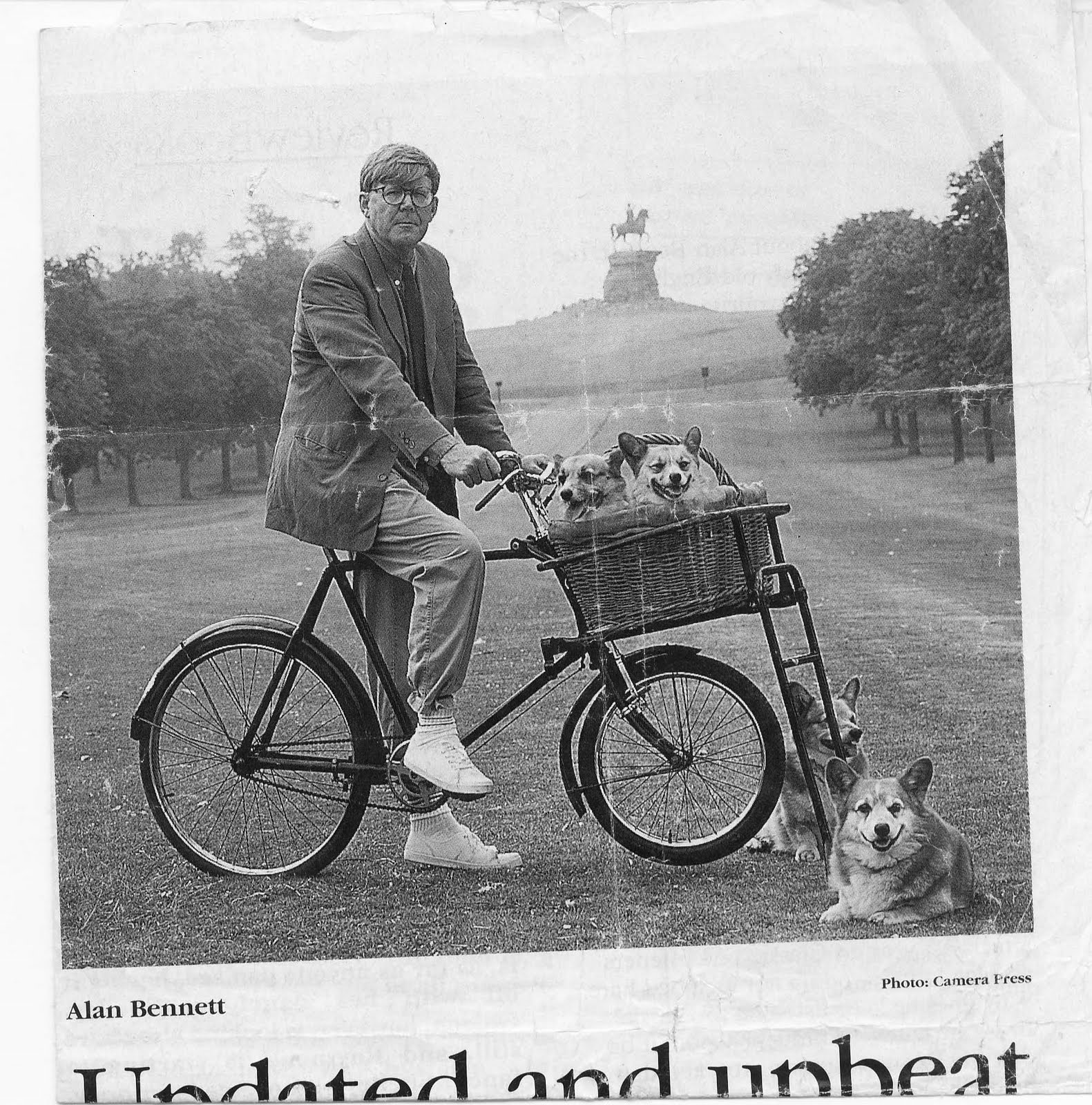Da che mondo è mondo di memoria labile, occorrono anniversari per fare il punto su orrori e vittorie. Il grigio che sta in mezzo figura perlopiù come indifferenza riempita di segnali, gesti, apparizioni atroci che innescano bombe fisiche e vergogne. Il grigio della sagoma opaca di chi ha diretto e assistito alla strage della “Morvillo Falcone” di Brindisi è il buio che cala sullo spettatore un secondo prima delle scene. Ciò non significa restare e resistere inermi, provare per forza noia passiva o affogare nello sgomento di un’altra giornata appassita. Significa anzitutto osservare e provare ad affrancarsi da quel grigio.
Da che mondo è mondo di memoria labile, occorrono anniversari per fare il punto su orrori e vittorie. Il grigio che sta in mezzo figura perlopiù come indifferenza riempita di segnali, gesti, apparizioni atroci che innescano bombe fisiche e vergogne. Il grigio della sagoma opaca di chi ha diretto e assistito alla strage della “Morvillo Falcone” di Brindisi è il buio che cala sullo spettatore un secondo prima delle scene. Ciò non significa restare e resistere inermi, provare per forza noia passiva o affogare nello sgomento di un’altra giornata appassita. Significa anzitutto osservare e provare ad affrancarsi da quel grigio.
Lo stesso vale per il calcolatore delle ossessioni, il mandante ed esecutore di una fine collettiva, quella maceria indelebile contro i giusti che oggi, 23 maggio, anch’io ricordo tornando a un pomeriggio in cortile. A una sfida a palla prigioniera, con i colpi sul portone del negozio di biciclette violenti e serrati, da bulli, ma senza vendetta.
Poi la notizia urlata dalla finestra, la voragine di Capaci e quel silenzio che iniziava a calare sulle teste sudate senza reale coscienza, più immobile di qualsiasi altro lutto indotto da commemorazioni pubbliche. Eravamo spettatori seduti l’uno di fronte all’altro con i tagli alle ginocchia e nessuna distanza dalla ripetizione a catena delle immagini sull’autostrada deflagrata.
Lo spettatore è l’apparizione durante e dopo il fatto, posa la palla ignaro e corre in casa. Ma può anche erompere da dietro un chiosco con una telecamera puntata a sua insaputa, e da lì innescare la rabbia contro addomi imberbi. Serve allora coprirsi, mettersi in salvo. Serve il disagio del non fiatare più, serve un’ennesima volta il poeta ammiraglio che confronta quel che lo spettatore ha solo osservato:
«Dopo ogni guerra
c’è chi deve ripulire.
In fondo un po’ d’ordine
da solo non si fa.
C’è chi deve spingere le macerie
ai bordi delle strade
per far passare
i carri pieni di cadaveri.
C’è chi deve sprofondare
nella melma e nella cenere,
tra le molle dei divani letto,
le schegge di vetro
e gli stracci insanguinati.
[…]
C’è chi, con la scopa in mano,
ricorda ancora com’era.
C’è chi ascolta
annuendo con la testa non mozzata.
[…]
Chi sapeva
di che si trattava,
deve far posto a quelli
che ne sanno poco.
E meno di poco.
E infine assolutamente nulla.
Sull’erba che ha ricoperto
le cause e gli effetti,
c’è chi deve starsene disteso
con una spiga tra i denti,
perso a fissare le nuvole».
Wislawa Szymborska, da La fine e l’inizio







 Le ragioni della memoria, il dibattito incrociato sui regimi e il loro primato di nefandezze, la griglia degli impotenti disprezzati e torchiati fino allo stremo dalla banalità del male. Coloro che non hanno retto il peso della propria intelligenza e si sono gettati lungo la tromba delle scale. La sagoma della nave mostro sospesa sull’acqua prima d’essere sommersa e mai salvata coi corpi di chi ha ceduto il posto di salvezza. Il regista greco “poeta della storia” che finisce travolto da una moto nel cuore della civiltà dopo che il regista video-artista ha mobilitato camionette per il diritto a una messinscena sul volto cristiano.
Le ragioni della memoria, il dibattito incrociato sui regimi e il loro primato di nefandezze, la griglia degli impotenti disprezzati e torchiati fino allo stremo dalla banalità del male. Coloro che non hanno retto il peso della propria intelligenza e si sono gettati lungo la tromba delle scale. La sagoma della nave mostro sospesa sull’acqua prima d’essere sommersa e mai salvata coi corpi di chi ha ceduto il posto di salvezza. Il regista greco “poeta della storia” che finisce travolto da una moto nel cuore della civiltà dopo che il regista video-artista ha mobilitato camionette per il diritto a una messinscena sul volto cristiano.