Ora.
Io sono un filosofo.
Cosa significa?
Si parla con cognizione di causa, le parole valgono.
Significa (etimologicamente) che dovrei essere affine (vicino) alla sapienza.
Mi chiedo cosa siano l’affinità e la vicinanza, e poi mi chiederò cos’è la sapienza.
Per ora so – dalla tradizione in cui sono stato educato – che essere filosofo significa che dovrei com-prendere (fare mio, inglobare, inserire in me), ovvero percepire (ma sono forse un’antenna per voci che sussurrano?) l’essenza delle cose (che non sono solo gli oggetti materiali, ma tutto ciò che è pensabile e possibile, e quindi anche ogni concetto o sentimento), del mondo e degli esseri umani, della loro coscienza.
Termini complessi, dove com-plesso vuol dire proprio con molti rimandi, con molti snodi.
Il pensabile ed il possibile definiscono uno sfondo interpretativo, che già arbitrariamente ignora mondi interi.
Ogni diversa interpretazione di questi termini, ogni diverso mondo in cui questi esistono rimanda ad una scuola, ad un’interpretazione differente, ad una vita diversa.
Ora mi serve porre alcuni distinguo.
Io so rispondere a questi quesiti, per cui sono un filosofo.
Io invece non so se sono un poeta.
Perché?
Perché la domanda del poeta è tale da eludere il linguaggio.
Nessuno può dire di essere un poeta, mentre si può dire di essere filosofo.
Il poeta trasforma la lingua: il filosofo la scava.
Il poeta sfiora con il suono il senso: il filosofo circonda la risposta alla sua domanda.
Il poeta illude il valore, che si crede realizzato, ma poi lo soffia via, come i semi di un tarassaco.
Vorrei accennare ad una delle domande lasciate in sospeso, ovvero cosa sono l’affinità e la vicinanza. Non per rispondere, ma per sottolineare come la diversa percezione di queste misure è proprio il metro della tangenzialità di filosofia e poesia.
Entrambi difatti pongono le stesse domande, e conoscono le stesse risposte.
Heidegger si pone la questione su cosa sia la vicinanza (ne “La cosa”) e capisce che l’uniformità dettata dall’assenza della distanza, oggi esasperata dalla rete, ma già totalmente intuita dal filosofo tedesco, è terrificante, proprio perché “tutto si confonde nell’assenza di distanza”.
“[il terrificante] si mostra e si nasconde nel modo in cui ogni cosa è presente”.
Ovvero, è in ogni ente, è ovunque, è essenziale ad ogni ente. Difatti, nonostante ogni riduzione ed accorciamento delle distanze (che porta nella direzione opposta alle affinità) il terrificante continua a restare lontano, proprio perché è ciò che non vorremmo ne vedere ne comprendere.
Ogni essere umano che abbia posto lo sguardo su Medusa, ascoltato le sirene, o gettato lo sguardo in un qualsiasi abisso o radicalità, chiunque si sia radicalmente posto le domande sul nostro senso e sul nostro valore, conosce le risposte, o per lo meno le risposte che la lingua dell’occidente gli permette di esprimere.
Ovvero che non esiste alcun senso, né alcuna logica, né alcun perché.
Tutto è vanità, da millenni lo sappiamo.
Questo è il terrificante: ciò che è sempre lontano, e ugualmente vicino come null’altro.
Ben che meno esiste alcun Dio, o un principio primo, ordine o motore immobile.
L’universo, o per lo meno quella percezione che noi ci illudiamo di condividere e che definiamo con questo nome, è solo caos, poiché le regole della fisica (classica, meccanica, relativistica, quantistica) come quelle di ogni altra scienza, non stanno nella cosa in se, bensì nello sguardo che la interroga, e quindi nella casualità della appercezione.
Perlomeno questo ci permette di comprendere la storia della nostra cultura, ovvero la storia di un’investigazione, della ricerca di un colpevole.
In fondo si tratta di un paradigma giudiziario.
Dio, giudice supremo, concede la grazia ad Isacco, e permette a suo padre Abramo di non eseguire il sacrificio, instaurando la filosofia del perdono, ma con questo non elimina la norma, la ricerca della prova, che resta e si incista, e per la quale stiamo ancora cercando un colpevole.
Nessuno si è mosso dal detto del Sileno: il nulla è ciò che ci meritiamo, originariamente peccatori, e sopravvissuti per forza, più che per diritto.
Nietzsche ci dice che l’Universo è una stella danzante, e vuole in questo modo, con un gesto disperatamente funambolico, provare a scollegare l’esistente dalla ricerca della sua causa (del colpevole), e quindi da un ben regolamentato insieme di codici (che siano religiosi, scientifici o giuridici poco conta), ed a connetterlo piuttosto con la sua bellezza, con il suo essere opera d’arte, ovvero con qualcosa che – in se e per se – è impermanente.
Ecce Homo. Zarathustra è una guida eccellente e puntuale su questo cammino, ma è necessario tornare indietro nel tempo, all’inizio del cammino che permette a Nietzsche stesso di giungere così lontano.
Infatti è solo il recupero dell’antica dimensione temporale intesa come circolarità, ovvero il tema dell’ourobos, dell’eterno ritorno dell’identico. che gli permette di alzare lo sguardo oltre, e cercare un’umana figura differente, finalmente libera, gioiosa e ardente del fuoco sacro.
Oggi il pensiero occidentale si è azzerato nella sua parcellizzazione.
Diatribe che nulla hanno a che vedere con la sua luminosa – per quanto devastante – storia di violenza. La filosofia politica, la filosofia della scienza, la morale, l’estetica, la logica, la filosofia del linguaggio, comunque rimangono percorsi paralleli, e spesso divergenti, dalla via tracciata dell’ontologia.
Il pensiero parmenideo aveva posto quel primo tassello, il ben noto frammento 3, secondo cui “… l’essere e il pensare sono lo stesso” (to gar auto noein estin te kai einai). Ovvero non vi è alcuna distinzione, nessuna discrepanza, nessuno slittamento tra il concetto che risiede tra i miei neuroni e la realtà delle cose.
L’ontologia medioevale senza allontanarsi di molto, pone i cardini di un’immensa e bimillenaria costruzione mediatica e dottrinale, quattro tasselli, quattro pietre miliari: i Trascendentali. Ovvero ciò che in modo totalmente immediato, quindi senza simbologie ne rimandi di alcun genere, appartiene (e quindi definisce) l’ente stesso. Questo quindi, per definizione, è unum, verum, bonum. Avicenna dice: “tres conditiones concomitantes esse” Ovvero che queste caratteristiche sono le proprietà di ogni essere (in quanto esistente). Sulla distinzione tra essere ed esistenza sono stati scritti trattati, ma ora qui non sposta più di tanto il nodo della questione. La prima trattazione sistematica dei trascendentali si trova nel Prologo alla Summa de Bono di Filippo il Cancelliere, che si preoccupa soprattutto di fondare in un platonico sommo bene l’origine (la causa, la colpa !!) di tutto l’universo. Ciò che però conta è il passaggio dell’aquinate, che nelle Quaestionaes Disputatae, vado a memoria, mi pare la numero 8, intitolata appunto De veritate arriva al nodo, e dice: “veritas est adaequatio intellectus et rei”. Nulla di molto diverso da ciò che in fondo ci aveva già detto Parmenide, ovvero che la realtà è ciò che trovi nella tua testa. Il tuo pensiero, il tuo intelletto, la tua capacità di scoprire le prove, di individuare (e punire) i colpevoli sono i capisaldi dell’esistenza stessa dell’universo, della sua verità, della verità stessa di Dio. In fondo sono principi che, pur nel loro essere fondativi, si rivedono facilmente nella filigrana dell’esistente. L’unicità dell’ente, ovvero il suo essere conchiuso in se, la delimitazione, la piega temporale in cui si cuce il bozzolo, è l’arcano del solipsismo novecentesco. Impedisce la promiscuità, la confusione: ogni cosa deve essere al suo posto, nell’ordine di Dio e dell’isteria. Dio in fondo all’inizio del secolo scorso si è trasformato in un’impettita educatrice, che in fondo cerca di mettere in riga Heidi, molto più prossima alla verità di quanto si pensi. Eraclito diceva che physis kriptestai filei ovvero che “la natura ama nascondersi”, e certo non ama mostrarsi a chi non se ne riconosce parte.
E nello stesso modo ogni cosa, in quanto esistente, appartiene alla verità, ed automaticamente alla realtà, che si contrappone direttamente alla falsità illusoria degli inferi. Hegel, senza spostarsi di un passo, dirà che ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale. Dov’è posta l’analogia? E’ evidente la totale identità di vedute tra Parmenide, Tommaso e Hegel.
Il gioco è fatto. L’ente si identifica da se, trovando il suo posto nell’ordine universale, è vero perché corrispondente alla Cosa in se, secondo le regole della razionalità, e quindi è, nel senso che esiste, è reale. Il cerchio dell’ontologia si è chiuso, e Dio (sommo bene) ne è il chiavistello, la spiegazione, la cifra interpretativa.
Peccato che non funziona.
Perché Dio non esiste, la ragione nemmeno, anzi, è ben più nota la follia, la verità non ne parliamo, al massimo è arte retorica, è libertinaggio, teatro, seduzione, e l’ente in se e per se …… insomma si è disperso, tra i punti di vista, nelle rappresentazioni, tra scettici e genie malin.
Povero occidente, quasi quattromila anni di riflessione, per ritrovarsi con polvere, rovine, qualche frammento di conoscenza. Restava solo da berci sopra.
Ed è proprio quello che fa Heidegger.
[fine prima parte]
.

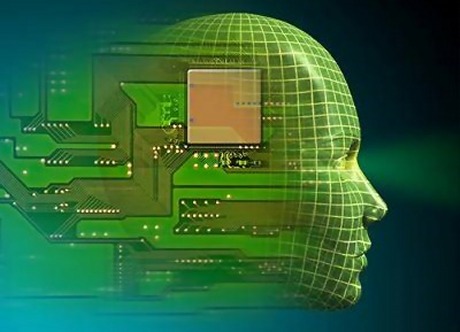
e anche io vado a farmi un bicchiere…
E’ sempre una buona idea ! salute !
Pingback: Tao Te Ching (în română) – Cartea despre Cale și Virtute