«Il calcinaccio era schizzato veloce di taglio sulla fronte di Flora e la pietra aveva fatto polvere e la carne aveva fatto scandalo, cioè sangue. Poi, il buio.
Altro non si ricordava, Flora, salvo che perse i sensi molto lentamente, con la grazia di un ballerino che si piega a qualcosa di sconveniente eppure inevitabile. Svenne inginocchiato, Flora, e sembrava chiedere perdono.
Tutto intorno prese a sciamare un terno secco di omini che un po’ se la ridevano e molto imprecavano verso la fascetta nera del Contenimento, riottosa a risalire sul braccio ma segno inequivocabile che a comandare erano loro, e la comanda era che i curiosi curiosassero pure ma lontani dal cornicione pericolante mentre loro dispiegavano il Soccorso Pronto.
Flora rimase inginocchiato per una buona mezz’ora, poco disturbato dal protocollo di sicurezza che ristabiliva l’ordine sconvolto di Torello.
Di fronte c’era un maxischermo che continuava imperterrito a trasmettere immagini mute in diretta da Berlino, dove una piccola folla si affrettava ad attraversare una via ingolfata dal traffico a piedi mentre un’incoerente bolla di palloncini rossi si stava alzando al cielo nel freddo di quella che una volta si chiamava Germania.
A Torello il capannello intorno alle immagini si stava infittendo, incoraggiato dai tizi del Contenimento, e i bravi cittadini si godevano Berlino by night.»
(Piero Calò, La penultima città, Las Vegas edizioni, Torino 2013, p. 9)
Torello.
In un futuro non remoto, la Giolla Unita ha sostituito i governi nazionali dell’Occidente, la moneta è stata abolita e rimpiazzata da una tessera a punti che garantisce a tutti i cittadini -occupati o meno- non solo la sopravvivenza, ma anche il mantenimento di un tenore di vita decente; l’improbabile triumvirato della “Beni, Vizi e Servizi” ha soppiantato le antiche amministrazioni locali, e i vecchi hobby hanno ceduto il passo a una gestione standardizzata e “meno libera” del tempo libero(1).
Le sorpassate aspirazioni sociali sono ormai surrogate dall’unica aspirazione ad accumulare l’oro(2) per potersi godere, prima o poi, un viaggio in una delle “Oasi felici” della Giolla(3).
A Torello ogni giorno esplode una bomba, ma i cittadini ci sono abituati, e nessuno si chiede più il perché; casomai, se capita di trovarsi sul luogo dell’esplosione, si pensa a soccorrere gli eventuali feriti, facendo poi rapporto alla “Beni Vizi e Servizi” per ricevere la spettante quantità d’oro come ricompensa per il servizio prestato. E poi nessuno si ricorda più del mondo com’era prima, quando le bombe non esplodevano.
In questa situazione tutt’altro che rosea, Nino Flora cerca disperatamente un lavoro (forse per potersi dichiarare alla sensuale coinquilina “Michela Gang Bang”, regina delle “Badasse”di Torello(4)); Giona Paraponzi, invece, un lavoro non lo vuole: la sua giornata si divide tra atti d’eroismo tutt’altro che disinteressati, sessioni di pesi nella palestra di Toni Dattoni, puntatine al Cagibì, e serate in casa con la moglie Anna Calacchi.
Tutto pare destinato a un’eterna, deprecabile stabilità, ma l’arrivo a Torello di un sinistro personaggio, le oscure trame di una misteriosa voce che sembra manovrare i gestori della “Beni, Vizi e Servizi”, e gli improvvisi lampi d’autocoscienza dei protagonisti danno il via a una serie di pesanti stravolgimenti…
A tre anni dall’esordio con il pregevole L’occhio di Porco, Piero Calò torna in libreria con La penultima città, romanzo ferocemente distopico, atrocemente comico, realistico in maniera preoccupante; una narrazione preziosa e irriverente che trova la sua collocazione in una terra di confine posta da qualche parte tra il Pynchon de L’arcobaleno della gravità e il Will Self dell’intraducibile Book of Dave, tra l’incollocabile Antrim di Votate Robinson per un mondo migliore e le Memorie di un malato di nervi di Schreber(5).
La trama principale è, ovviamente, legata alla distopia; semplificando al massimo, il genere, con tutte le sue varianti, offrirebbe un paio di sviluppi possibili: da un lato una conciliante “soluzione”, con una conversione del sistema “totalitario” in democratico (o almeno una promessa, una speranza di conversione), dall’altro un finale apocalittico(6). In entrambi i casi, l’esito rischierebbe di sembrare prevedibile, come spesso capita nei romanzi distopici moderni; qui, invece, l’autore esce dall’impasse ricorrendo a un finale aperto che, nutrito com’è di sviluppi possibili e dubbi destinati a rimanere non sciolti, delega al lettore il compito di tirare le fila della vicenda(7).
All’interno della riuscitissima trama distopica si innestano innumerevoli sottotesti e trame secondarie, che permettono all’autore di affrontare tematiche quali il ruolo dell’intrattenimento nella costruzione del consenso, le scelte controculturali (dalla lotta armata all’uso di stupefacenti al radicalismo religioso ecc.) e il loro fallimento, il senso e la considerazione dell’arte nelle società totalitarie(8), la genetica(9), il doppio, la crisi dell’identità e della memoria(10) ecc.
La vicenda è raccontata da un narratore onnisciente extradiegetico che assume ora il punto di vista di un personaggio, ora quello di un altro, ricorrendo, ogni tanto (raramente, molto raramente), a effetti di parallissi utili a consolidare l’attenzione del lettore.
Lo stile è uno dei punti di forza del romanzo: come ne L’occhio di porco, anche qui, Calò si serve di una lingua inventata eppure familiare, straniante ma immaginifica, evocativa; una lingua che è l’esito possibile (o forse probabile), della contaminazione in atto nell’universo della narrazione. Se nel primo romanzo il punto d’arrivo della ricerca linguistica era una sorta di strano dialetto generato dalla chiusura della “Tessera”(11), qui, il naufragio della sintassi si trova in un certo senso a rappresentare lo scacco della capacità di ragionamento(12), mentre la convivenza (ma anzi, la giustapposizione) di termini provenienti da contesti semantici lontanissimi (quando non opposti), e il salto irregolare e indiscriminato dal registro basso all’alto, rimandano al carattere residuale del linguaggio: il lessico è ormai il prodotto di un accumulo; le espressioni dialettali sono vecchie e omogenee (nella Giolla non c’è più varietà perché non c’è più movimento), i vocaboli derivanti dai campi della religione, del lavoro ecc., sono semplici relitti, sopravvivenze; segni vuoti; termini ormai privi di referenti, che testimoniano di una censura perennemente in atto, di una rimozione sempre in corso d’opera.
Forse è più nella scelta linguistica che nel credibilissimo contenuto distopico(13), che il romanzo di Calò dimostra il suo compiuto realismo: nella perfetta uniformità tra realtà descritta e lingua utilizzata(14); è proprio a questo che tende La penultima città: alla tautegoria. All‘indivisibilità, alla perfetta corrispondenza di forma e contenuto.
E nel farlo -nel servirsi di questa voce che, esprimendosi con una sintassi sconnessa e residuale, e un lessico eteroclito, quasi “post-apocalittico” (o decisamente post-apocalittico, almeno in senso culturale), inorganico e in parte vuoto, assolve così bene alla funzione realistica e mimetica- l’autore riesce anche a mantenere un ritmo invidiabile e costruire degli effetti di grande comicità.
In poche parole, un piccolo miracolo…
La penultima città di Piero Calò è edito da Las Vegas edizioni.
(1)In sostanza, gli svaghi offerti (imposti?) agli abitanti della Giolla sono il bordello istituzionalizzato del Cagibì (il vecchio Hotel Gramsci), gli allenamenti in palestra e le soste quasi obbligate davanti ai maxischermi (inaugurati il 14 luglio, come a testimoniare che in fondo l’esito ultimo -o perlomeno un esito probabile- della rivoluzione borghese è l’annullamento dell’ideale democratico, la sua implosione in uno stato oscuramente totalitario) installati a ogni incrocio e che, trasmettendo ventiquattro ore su ventiquattro delle tranches de vie provenienti dai quattro angoli della Giolla, sembrano “guardare” gli spettatori più che esserne guardati. Il tempo libero è, per dirlo con Horkheimer e Adorno, una sorta di “prolungamento del lavoro meccanizzato”, per quanto questo possa sembrare paradossale in un mondo in cui non si produce più nulla.
(2)Aspirazione ampiamente fomentata dai rappresentanti della “Beni, Vizi e Servizi”: “Non dimentichi di accumulare l’oro! Non si faccia scrupoli!”, si legge, per esempio, a p. 55, ed è solo una delle prime occorrenze di quello che il lettore riconoscerà come un vero e proprio mantra degli amministratori della Giolla.
(3)Proseguendo nella lettura, il lettore si renderà conto che “Oasi felice” è in realtà una dicitura standard per ogni città e paese della Giolla, e che la grande ambizione dei cittadini si riduce a un semplice spostamento nello spazio verso luoghi assolutamente identici a quelli di provenienza.
(4)Le escort/prostitute del Cagibì.
(5)Che dire, altrimenti, dell’esuberanza simbolica di certe sequenze oniriche intrise di elementi psicanalitici? (cfr., per esempio, il capitolo relativo al “bestio”, pp. 248-252).(6)Questo volendo rispettare la figura minimale della narratologia indicata Greimas, ovvero equilibrio-squilibrio-riequilibrio; anche se qui quello che con tutte le riserve del caso chiameremmo “equilibrio” (la società contemporanea, con tutti i suoi inghippi), è scomparsa da circa una quindicina d’anni per lasciare spazio al peggio: la Giolla unita.
(7)Certo, qualche indizio c’è: come si legge nel titolo, la Torello del romanzo è la “Penultima città”, e non l’ultima…
(8)Flora ha scritto due libri senza importanza, roba che nessuno ha mai sentito, “ma gli alberi li hanno tagliati comunque”, commenta sarcastico un comprimario che sembra uscito pari pari dall’Italia contemporanea…
(9)Uno dei fortunati personaggi minori del romanzo, il macellaio Tiziano, è riuscito a selezionare una nuova razza bovina: la caramolla, una mucca composta di solo Filetto.(10)L’osservazione di tutti gli aspetti identitari e relativi alla “perdita della memoria” presenti nella vicenda richiederebbe pagine e pagine; valgano come indizi la menomazione invisibile di Michela -il marchio di un passato a noi ignoto, che siamo portati a credere sia tale anche per lei-; l’improbabile mutamento di Serena e l’incapacità di Flora di adattarvisi; l’incapacità di Anpichisi (entrato in scena con i paramenti da chiesa, e quindi in un certo senso garante della tradizione, dei valori tradizionali e della memoria), di individuare Giona Paraponzi (il vecchio finisce infatti per scambiarlo con altri, in una terribile accozzaglia di parabole bibliche e confusioni letterarie (cfr. p. 305)); e la lunga sequenza relativa alla costruzione dello specchio, attività che Flora e Giona portano avanti come nel tentativo di rispondere con il “fare”, con la “pratica”, a un problema spiccatamente culturale e identitario (ricostruire per riconoscersi, e quindi in un certo senso ricostruirsi e ritrovare la memoria); si noti peraltro, che proprio la ricostruzione dello specchio raffigura, nella pratica, l’inconsapevole agire linguistico dei personaggi – una sorta di bricolage, un’attività fondata sul riuso di materiale sopravvissuto alla rimozione, in cui vocaboli stridenti, frammenti di linguaggi diversi, vengono accosti tra loro, come i pezzi di vetro colorati sono ri-assemblati con lo scotch e malamente, in maniera sconnessa – forse anche deformante (tant’è che lo specchio restituisce l’immagine di due personaggi mutati: Serena -ingrossata- e Michela -scheletrica-).
Proprio di fronte allo specchio i due personaggi femminili si rivelano per quello che sono: uno il doppio dell’altro, e in quanto tali si prestano a una sostituzione, che, se è già avvenuta al principio (spostamento del desiderio dall’una all’altra) è pur sempre reversibile.
Ancora, per quanto riguarda il doppio, si noti la simmetria tra la triade dei “Micheli” della “Beni, Vizi e Servizi”, e la dimenticata trinità di “Questo”, “Codesto” e “Tale”…
(11)Il paese d’ambientazione de L’occhio di Porco; una sorta di énclave posta in una non ben precisata zona del sud Italia.
(12) Perché chi pensa male parla male, e viceversa, e qui i personaggi sono costretti a pensare attraverso le briciole, gli avanzi di pensieri passati, e i discorsi (anche quelli specifici, come le preghiere), dove non sono dimenticati, hanno perso il loro senso originale. (13)La società descritta da Calò sembra l’esito di una sorta di incubo hegeliano in cui gli uomini sono stati ri-educati (in un senso quasi maoista), a essere buoni cittadini, ma buoni cittadini di uno stato che non ha buone leggi (d’altra parte, la loro educazione è avvenuta al di fuori della famiglia: nella nuova società, infatti, gli stessi legami familiari sembrano mobili, allentati se non proprio recisi); gli abitanti della Giolla sono ormai, conformemente con la massima aspirazione dei governanti di tutti i tempi, “uomini felici e cittadini modello”.
Certo se si ammette l’allegoria come chiave, e/o la scelta dell’iperbole come cifra stilistica, niente ci impedisce di riconoscere la realtà descritta da Calò come l’esito razionalmente possibile di una serie di processi già in atto.
(14)Persa la fiducia nelle grandi metanarrazioni (Lyotard), l’uomo postmoderno ha finalmente abbandonato anche la vana speranza di poter stendere descrizioni oggettive, puri resoconti di stati di cose. Cadute le premesse, il vecchio realismo non ha più senso di esistere. E infatti oggi ci si accontenta della verosimiglianza; della condensazione di un contenuto quasi statistico. E, quando si parla di realismo, sempre più spesso ci si riferisce (e a ragione), all’adeguatezza dei mezzi narrativi ai fini narrativi.

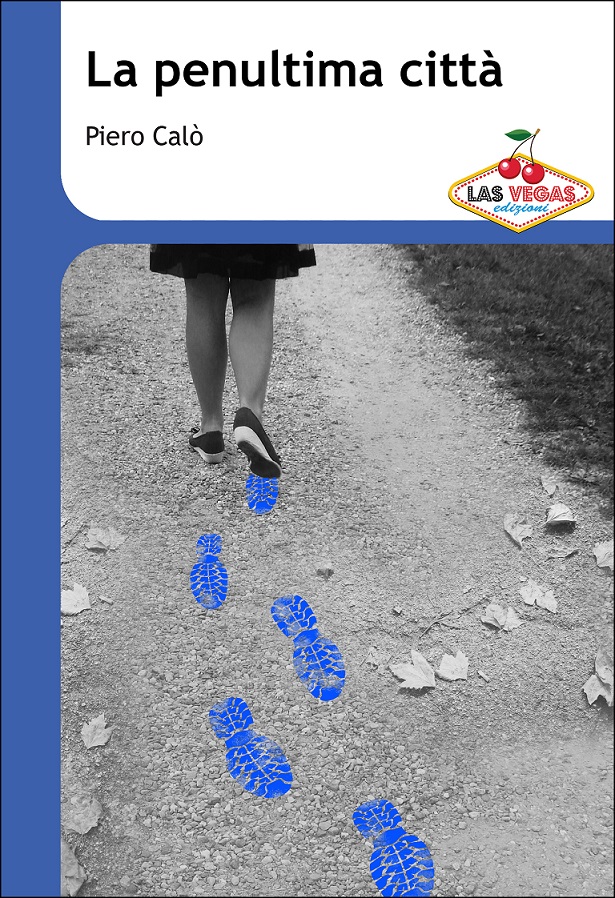

Pingback: La penultima città su Non solo noir - Las Vegas edizioni